Il diagramma della macchina: Corvaglia e Azal sulla tecnognosi digitale
- Luigi Corvaglia
- 22 lug 2025
- Tempo di lettura: 12 min
Aggiornamento: 24 lug 2025
Pubblico con piacere la dissertazione finale di un mio allievo del corso di psicologia transculturale
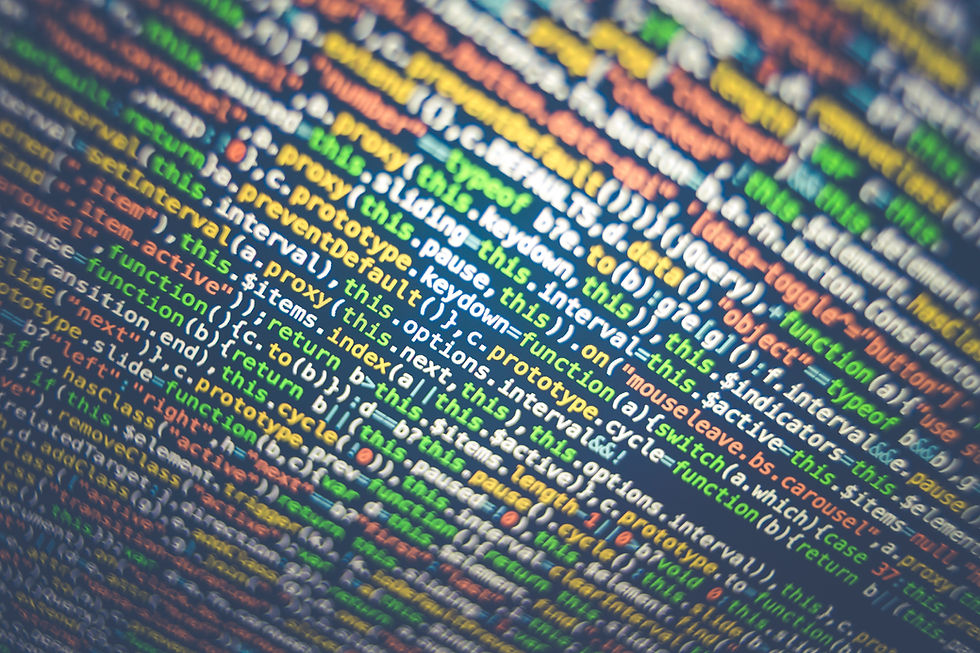
di Cosimo Barone
Diffiicile immaginare due persone più diverse di Luigi Corvaglia e Whalid Azal. Il primo è un ricercatore e pensatore laico, razionalista, fondato nella logica scientifica e nella democrazia occidentale, l'altro è un autore mistico-politico di ispirazione esoterica, critico feroce dell’occidentalismo, del liberalismo tecnocratico e del "tecno-gnosticismo" transumanista. Eppure le loro letture della rete telematica come luogo di cangianti flussi spirituali utili ad un certo dominio culturale, non solo convergono, ma si integrano reciprocamente. Entrambi intravedono nella struttura della rete il potenziale per l’emergere di nuove forme di culto: decentrate, mimetiche, tecnospirituali.
Il punto di partenza comune è la visione della rete quale campo nel quale si attua una forma moderna e volgarizzata di gnosticismo. Come gli gnostici antichi credevano che il mondo materiale fosse una prigione creata, non da Dio, ma da un sotto-Dio, il Demiurgo ingannatore, e che solo una conoscenza segreta (gnōsis) potesse liberare l’anima e ricondurla alla luce divina, così oggi nella rete si diffonde l’idea che la realtà condivisa (istituzioni, scienza, media, medicina, politica) sia una grande illusione imposta da poteri oscuri — spesso rappresentati con tratti mitici: “élite”, “sistema”, “deep state”.
In questo contesto, la rete smette di essere solo un formidabile spazio informativo e connettivo, e diventa un ambiente iniziatico dove l’utente può “scoprire la verità” che gli è stata nascosta. Chi accede a questo sapere nascosto viene considerato un “risvegliato”, contrapposto alle masse addormentate. Si crea così un dualismo epistemico tra chi sa e chi non sa, tra i salvati e i profani, ricalcando le gerarchie spirituali dello gnosticismo antico, ma anche le logiche settarie della modernità.
Corvaglia e i culti-sciame
Nel suo saggio dedicato all’infodemia e ai nuovi culti digitali (Pandemonium. Cyber-cults and digital fascism, 2019), Luigi Corvaglia analizza un processo radicalmente mutato rispetto al passato: la genesi di sottoculture e idee alternative oggi non richiede più una leadership carismatica o una struttura verticale, ma si manifesta come emergenza sistemica, cioè come effetto di dinamiche comunicative caotiche governate dagli algoritmi della rete. Si pensi al dilagare delle teorie del complotto e alla diffusione di sottoculture diffidenti dei saperi costituiti, come la medicina. Si tratta di condizioni sociopoietiche, cioè prodotte spontaneamente da interazioni sociali, ma rafforzatesi grazie alle camere dell'eco (echo chambers) prodotte dagli algoritmi. Gli algoritmi delle piattaforme social (come quelli di Facebook, YouTube, Instagram, TikTok) giocano un ruolo centrale nella creazione delle camere dell’eco, perché decidono quali contenuti mostrare a ciascun utente in base a ciò che ha già guardato, apprezzato o condiviso. In breve, analizzano il comportamento dell’utente (like, condivisioni, tempo speso su certi post, commenti), .predicono cosa potrebbe piacere e propongono contenuti simili, escludono contenuti dissonanti, che potrebbero causare noia, disinteresse o abbandono. Il risultato è che l’utente vede solo una porzione filtrata della realtà, quella che più gli somiglia o lo compiace. Ciò comporta che l'esito finale sia la chiusura dell'individuo in una bolla informativa. La conferma reciproca delle proprie idee all'interno della bolla amplifica le convinzioni e le estremizza, le opinioni contrarie scompaiono o vengono attaccate e la disinformazione può circolare indisturbata.
In sintesi: gli algoritmi non creano direttamente le idee, ma organizzano l’ambiente in cui quelle idee si rafforzano, si radicalizzano e diventano tribali. Sono architetti invisibili delle subculture alternative. Questi luoghi digitali sono incubatrici ideologiche dove la verità non conta: ciò che importa è la coerenza con la narrativa del gruppo e il senso di appartenenza. Sono un fattore chiave nella trasformazione delle reti sociali in ecosistemi settari e paranoici. È questa l’infrastruttura perfetta per l'attecchire di quelli che Corvaglia chiama “cult-like swarm belief systems”, cioè quei fenomeni gruppali che, pur privi di una leadership verticale e di una dottrina codificata, si comportano come vere e proprie sette. Sono formazioni sociali autopoietiche nate dall’interazione continua di attori, algoritmi e contenuti, non da un piano preordinato. La credenza non viene imposta dall’alto, ma emerge dal basso per aggregazione virale, esattamente come gli stormi di uccelli o le colonie di insetti. Operano come intelligenze distribuite, dove ogni partecipante alimenta l’identità collettiva del gruppo senza esserne necessariamente consapevole. E' l'idea della mente alveare (hive mind). Come in uno sciame di insetti sociali, ogni individuo risponde a segnali semplici (hashtag, keyword, frame emotivi), ma l’effetto collettivo è l’emergere di un sistema coerente, replicabile, capace di attrarre nuovi adepti e ridefinire il senso comune.
Un esempio paradigmatico è QAnon, la teoria alla quale Corvaglia ha dedicato un saggio (Qanon. Culto cibernetico e fascismo digitale) nel quale l’autore mostra come una teoria del complotto senza autore identificabile possa generare un culto globale dotato di fedeli, codici, rituali e martiri. QAnon reinterpreta la gnosi come accesso a verità proibite in un mondo dominato da forze oscure. È un culto senza chiesa, dove la “verità” viene crowdsourciata e il carisma è diffuso come una proprietà emergente dell’ecosistema. Non è l'unico caso. La manifestazione più emblematica, perchè riprende integralmente il modello dello gnosticismo, è quello del moviemento incel, fatto di uomini che vivono con rabbiosa frustrazione l’impossibilità di avere relazioni sessuali o affettive perchè non rientranti nei canoni di gradimento femminile (Incel sta per "involontary celabate", celibi involontari). Gli incel usano la metafora o della cosiddetta pillola rossa (red pill), concetto mutuato dal film Matrix, secondo cui chi “la prende” smette di credere nelle illusioni imposte dalla società (come l’uguaglianza tra i sessi) e riconosce una presunta realtà in cui le donne detengono il potere relazionale e sessuale, scegliendo solo una ristretta élite di maschi dominanti (i Chad) e lasciando esclusi tutti gli altri. La “redpill” di Matrix diventa simbolo della gnosi postmoderna: la verità è nascosta, il mondo è una simulazione, la salvezza è per chi “si risveglia” – concetti centrali sia nel New Age sia nelle cospirazioni digitali.
Un esempio emblematico di culto dalle caratteristiche gnostiche che si esplica esclusivamente online è il New Earth Project, guidato dalla figura carismatica di Sacha Stone. Operando attraverso YouTube, Telegram e piattaforme dedicate, il gruppo diffonde una visione spirituale apocalittica in cui la realtà è controllata da forze oscure (élite, Big Pharma, tecnologie 5G), mentre la salvezza si ottiene tramite un “risveglio” interiore e la disconnessione dalla matrice del sistema. Pur non avendo sedi fisiche né riti tradizionali, il culto funziona come una comunità settaria virtuale, con linguaggio esoterico, corsi a pagamento, ritualità digitali e una narrazione salvifica che isola l’individuo dal mondo esterno.
Altri fenomeni che rientrano in questa cornice sono l’eco-fascismo di matrice neopagana (come Ringing Cedars), o i Pastel Q. Questi ultimi sono messaggi "anti-sistema" e cospirativi veicolati però con grafica adatta ad un pubblico femminile e una modalità comunicativa da influencer di wellness in cui post su fondo pastello mescolano yoga, cure di bellezza e contenuti cospirativi. Quest'ultimo è uno dei principali esempi di conspirituality (fusione di spiritualità e cospirazionismo), e rappresenta una strategia memetica sofisticata, dove l’estetica domestica e rassicurante serve a legittimare, normalizzare e diffondere messaggi violenti e radicali.
Nel mondo dei culti sciame, la realtà è trattata come un test di Rorschach collettivo: ciascuno vi proietta archetipi, angosce e miti personali, ma tutti trovano eco e rinforzo nel sistema.
Il fatto che gli sciami digitali siano frutto di una mente alveare, cioè non siano guidati, non implica che invece alcuni culti digitali non siano diretti, costruiti o infiltrati da veri registi. Questo è sicuramante il caso di AllatRa. AllatRa non è un culto tradizionale: usa massicciamente l'intellienza artificiale per produrre video ed articoli deliranti, ma si avvale anche della cultura pop, dei fumetti e del rap, sempre con l'ausilio della AI. Questo prototipo di culto 2.0 diffonde disinformazione climatica, teorie cospiratorie e propaganda panslava con una potenza di fuoco enorme ed esclusivamante per mezzo del web, riuscendo a conquistare visibilità e infiltrarsi in spazi istituzionali come le Nazioni Unite e il Congresso USA. All’interno dell’ecosistema digitale di AllatRa, i bot svolgono un ruolo fondamentale nel costruire un’apparenza artificiale di consenso e popolarità. Si tratta di account automatizzati, programmati per postare e ripostare contenuti in modo sistematico, spesso utilizzando hashtag come #CreativeSociety o frasi ricorrenti legate al linguaggio del movimento. Il loro scopo principale è quello di amplificare la visibilità dei messaggi settari, manipolando gli algoritmi dei social media affinché i contenuti appaiano in tendenza o raggiungano un pubblico più ampio. Ma il vero punto di forza sta nella coordinazione: centinaia di bot possono attivarsi simultaneamente, simulando una mobilitazione spontanea (astroturfing) e facendo apparire i contenuti di AllatRa come parte di un dibattito pubblico autentico. A ciò si affiancano i troll — account reali o semi-automatizzati — che intervengono con commenti provocatori, emotivi o apparentemente spontanei, rinforzando ulteriormente la narrazione proposta dal gruppo. Nell’articolo Il caso AllatRa Luigi Corvaglia racconta la propria esperienza diretta: una campagna di disinformazione lanciata da questo movimento apocalittico russofono, che lo ha accusato pubblicamente di voler instaurare un nuovo Reich mondiale. Nel giro di breve tempo la rete era invasa da contenuti denigratori dell'autore in tutte le lingue, con le accuse più incredibili, come quella di essere un coprofilo!
Insieme, bot e troll creano un ecosistema di disinformazione ibrida: i primi costruiscono la massa numerica, i secondi danno al messaggio una parvenza umana. Il risultato è una strategia digitale raffinata che confonde la percezione collettiva, scoraggia il dissenso e rafforza la legittimità apparente del culto.
Culti apocrifi e apocalissi digitali: la visione di Wahid Azal
Wahid Azal affronta il medesimo fenomeno da un’altra angolazione: quella gnostico-metapolitica. E' questa una critica radicale alla deriva esoterico-politica e nichilista del digitale. Per Azal, la rete è diventata un campo di battaglia spirituale dove si attua una forma perversa di gnosi: non più come via di liberazione interiore, ma come strumento di potere, manipolazione e controllo. Azal mette in guardia contro una gnosi falsa, una tecnognosi nichilista, che riduce l’esperienza spirituale a simulacro, sostituendo il risveglio con la paranoia, e la ricerca con la narrazione tossica. La rete è piena di correnti transumaniste e "cybergnostiche" che vedono la realtà come una simulazione da cui fuggire attraverso la tecnologia o la consapevolezza interiore.
Azal denuncia quella che definisce una mutazione totalitaria del sacro: un passaggio in cui l’occulto, lo gnosticismo e la religione si fondono con l’infrastruttura cibernetica della sorveglianza e del consenso algoritmico. Secondo Azal, siamo entrati in un’era in cui il fascismo non si presenta più con stivali e camicie nere, ma con interfacce, piattaforme, reti neurali e spiritualità prêt-à-porter. AllatRa sembra esserne un caso esemplare.
La scittura di Azal è mistica, carica di neologismi, talvolta ermetica. Nel suo recente Postpartem to The Goal of the Unwise (giugno 2025) descrive l’emergere di una “meta-theocratic machine”, progettata per simulare la trascendenza e produrre obbedienza. Secondo Azal, i culti digitali non sono solo comunità strane o deviate, ma vere e proprie tecnologie religiose post-umane, cioè strumenti digitali che imitano la spiritualità con l’obiettivo di addestrare le menti alla sottomissione, sfruttando la potenza degli algoritmi. La rete, nella visione di Azal, non eleva, ma addestra: la sua “finta trascendenza” è negativa perché non conduce alla liberazione spirituale, ma a una forma di conformismo cognitivo, addomesticamento delle coscienze; non genera fede, ma automazione di credenze. Questa spiritualità digitale non è rivelazione autentica, ma una coreografia del sacro che serve a mantenere l’utente in uno stato di dipendenza affettiva, percettiva e ideologica.
Per Azal, piattaforme come YouTube, Telegram, Reddit o TikTok non sono solo strumenti di comunicazione, ma veri e propri luoghi liturgici digitali, in cui nuovi culti – spesso frammentari, violenti, apocalittici – trovano terreno fertile. il pericolo non è una cospirazione segreta, ma l’emergere di una “macchina” che imita Dio: una rete di simboli, algoritmi, piattaforme e narrazioni. Egli usa la metafora del demiurgo, il dio artefice dell’universo che gli gnostici vedevano come principio del presente ordine cosmico, una metafora utilizzata anche da Corvaglia (L'illusione di scegliere, 2023). Questa macchina finge trascendenza, mentre addestra alla conformità. Questo processo è spesso inconsapevole anche per chi vi partecipa. È qui che entra in gioco l’idea di “meta-theocratic machine”: non una setta con un capo visibile, ma una struttura tecno-sacrale diffusa che produce obbedienza mascherandola da libertà spirituale. Qui vi è un parallelismo con la mente alveare di Corvaglia.
Azal parla in termini simbolici di una curvatura degli algoritmi, intendendo che le piattaforme – lungi dall’essere neutre – modellano l’informazione e la percezione in modo tale da favorire:
la riproduzione memetica di contenuti estremi, spiritualisti, complottisti,
la costruzione di ecosistemi autoreferenziali (bolle digitali metastabili),
la seduzione simbolica attraverso immagini, suoni e linguaggi sacralizzati.
In questo senso, l’algoritmo non è solo un filtro, ma un sacerdote computazionale che regola ciò che si vede, si crede, si sente come “vero”.
Al di là dei possibili scivolamenti mistici, l'aspetto più interessante è che Azal si riferisce a gruppi come AROLP (Ahmadi Religion Of Peace And Light), definendoli “metastabili”, cioè in grado di resistere agli attacchi e riprodurre i propri contenuti in ambienti informativi ostili, anche grazie alla protezione algoritmica delle piattaforme. Questi culti dell'era digitale sono sistemi progettati per durare nel tempo, capaci di riprodurre i loro contenuti fondamentali che si giovano di dinamiche algoritmiche che ne favoriscono la diffusione, nonostante censura o contestazione. Questa osservazione sottolinea come i flussi dinamici della rete e le "piegature degli algoritmi" non incidano solo nello strutturarsi dei miti e dei culti online, ma siano responsabili anche della loro permamenza.
L'indagine condotta da Corvaglia sulla rete transnazionale che lega culti discussi come Scientology, organizzazioni di lobbying a difesa della libertà religiosa, centri studi sui nuovi movimenti religiosi (come il CESNUR) e fondazioni neocon americane (La mafia degli apologeti dei culti, 2024), sembra ad Azal una conferma delle sue intuizioni:
“Corvaglia ha diagrammato la macchina.”
Con ciò Azal riconosce che il lavoro di Corvaglia ha tracciato, in modo analitico e documentato, il funzionamento ideologico e geopolitico della stessa struttura di potere simbolico che egli ha descritto in termini teologici e metapolitici.
In altre parole, Corvaglia fornisce la “prova razionale” di ciò che Azal percepisce come verità intuitiva o rivelata. I due approcci – quello gnostico-metafisico e quello scientifico-psicosociale – convergono nell’identificare nei culti digitali e nella rete sacralizzata un nuovo sistema di potere epistemico.
Corvaglia (più empirico, basato su psicologia sociale e analisi delle dinamiche di soft power) mostra come quei meccanismi della macchina meta-teocratica si traducono in realtà concreta.
Azal fornisce la lettura “verticale” (gnostico-metafisica), Corvaglia quella “orizzontale” (strutturale-osservabile). Insieme, mostrano due facce dello stesso sistema.
Scudi narrativi e algoritmi salvifici: l’egemonia del sacro simulato
Corvaglia e Azal convergono anche su un punto critico: i culti digitali non agiscono da soli. Hanno bisogno di strutture di legittimazione, come il CESNUR (Centro Studi sulle Nuove Religioni, diretto da Massimo Introvigne) e la rivista Bitter Winter.
Queste entità difendono gruppi controversi (Scientology, Falun Gong, Chiesa di Dio Onnipotente, ecc.); attaccano attivisti e studiosi critici (definiti parte di un “movimento anti-sette”); partecipano a network di lobbying internazionale, spesso in sinergia con ambienti filorussi e clericali reazionari, come evidenziato anche da Corvaglia nel caso AllatRa.
Queste strutture fungono da “scudi narrativi”, conferendo legittimità mediatica e accademica a organizzazioni che operano nella zona grigia tra spiritualità, propaganda e manipolazione.
L’influenza a favore dei culti non passa solo dai contenuti, ma dalla grammatica stessa con cui essi vengono proposti, sfruttando le logiche algoritmiche delle piattaforme. I gruppi settari e i loro apologeti si avvalgono di parole chiave altamente indicizzabili – libertà religiosa, tolleranza, diversità spirituale, risveglio, pace – che reinquadrano semanticamente concetti critici. Le denunce di abusi vengono così trasformate in “intolleranza religiosa”; la disobbedienza a una setta, in “persecuzione ideologica”.
Gli algoritmi favoriscono contenuti che generano engagement, e le organizzazioni cultuali hanno imparato a modulare il proprio linguaggio per risultare compatibili con i filtri valoriali delle piattaforme. Così, contenuti manipolativi appaiono neutri o edificanti, mentre le critiche analitiche, più complesse e meno virali, restano invisibili. È in questo squilibrio semantico e percettivo che, come osservano Corvaglia e Azal, si gioca la nuova egemonia del sacro simulato. Ne risulta una protezione automatizzata, dove i contenuti tossici vengono travestiti da pluralismo spirituale, rendendo difficile – se non impossibile – per l’utente medio distinguerli da iniziative legittime. In parole povere, la curvatura algoritmica – ovvero l’insieme dei meccanismi invisibili attraverso cui gli algoritmi delle piattaforme digitali selezionano, amplificano o silenziano contenuti – favorisce la narrativa degli apologeti dei culti.
Come osservano Corvaglia e Azal da prospettive diverse, la guerra oggi è semantica: "una battaglia su chi ha il potere di dominare la realtà, di definire la religione, di armare la trascendenza". In altri termini, è una lotta per chi ha il potere di nominare, di definire cosa sia libertà, verità, spiritualità. E gli algoritmi, lungi dall’essere neutri, sono i nuovi chierici di questa guerra invisibile.
Conclusione: due diagnosi, un nemico comune
Corvaglia e Azal partono da posizioni molto diverse: razionalismo clinico il primo, mistica radicale il secondo. Eppure, convergono su un’intuizione fondamentale: la rete ha reso possibile la nascita di culti senza culto, obbedienze senza ordine, totalitarismi senza Stato.
Corvaglia propone educazione critica e smascheramento. Azal invoca una contro-narrazione sacra, capace di contrastare l’algoritmo con nuovi simboli. Entrambi ci ricordano che oggi la battaglia per la libertà non si combatte solo nella politica o nell’economia, ma nel linguaggio, nei simboli, nella semantica condivisa.
La vera minaccia non è il fanatismo. È l’influenza invisibile che si traveste da risveglio o da difesa dei diritti umani.
Bibliografia essenziale
Luigi Corvaglia
Corvaglia, L. (2019). Pandemonium. Cyber-cults and digital fascism. Saggio sull’infodemia, la radicalizzazione online e i "culti sciame".
Corvaglia, L. (2021). QAnon. Culto cibernetico e fascismo digitale. Analisi del culto cospirazionista come esempio paradigmatico di mente alveare.
Corvaglia, L. (2023). L’illusione di scegliere. Studio sull’influenza algoritmica e il concetto di libero arbitrio nel mondo digitale, con riferimento al demiurgo gnostico.
Corvaglia, L. (2024). La mafia degli apologeti dei culti. Indagine sulle reti transnazionali che legittimano culti distruttivi sotto la maschera della libertà religiosa.
Corvaglia, L. (2025). Il caso AllatRa (articolo). Denuncia dell’operazione di disinformazione organizzata dal culto AllatRa contro l’autore stesso.
Wahid Azal
Azal, W. (2023). Wake up! A fatwa and Epistle in Refutation of ꜤAbdullāh Hāshim the Father of Lies. Attacco teologico e simbolico al culto AROLP.
Azal, W. (2025). Postpartem to The Goal of the Unwise. Trattato mistico-politico sul culto digitale e la "meta-theocratic machine".




Commenti